I PORCOSPINI DI SCHOPENHAUER
- riccigianfranco199
- 9 giu 2024
- Tempo di lettura: 4 min
Arthur Schopenhauer è stato uno dei più importanti filosofi del XIX secolo, uno dei padri della Filosofia moderna e della Psicoanalisi, come ammesso dallo stesso Freud. La sua indagine filosofica costituisce uno dei pilastri della moderna concezione dell’uomo e del suo rapporto con il mondo.

Il pensiero di Schopenhauer si colloca a cavallo tra due mondi: da una parte la parabola dell’Illuminismo si è oramai esaurita. La fiducia nella ragione, nella concezione pedagogica dell’intellettuale ha lasciato posto alle vette impervie e liriche del Romanticismo. Concetti come “spirito”, “anima della nazione” e “identità” si fanno largo, animando le lotte che in tutta Europa accompagnano la nascita dello Stato – Nazione.
Dall’altra, lo sviluppo tecnologico non ha ancora imposto la tecnica come unico faro dell’agire umano, cancellando la soggettività e la storia dall’orizzonte filosofico e culturale.
La filosofia di Schopenhauer è quindi un sistema di pensiero ricco di riferimenti diversi; si tratta di una sintesi originale di cultura occidentale ed orientale (il filosofo era infatti molto interessato al pensiero orientale e in particolare al Buddhismo).
Tuttavia, è nella storia di vita di Schopenhauer che possiamo trovare una preziosa chiave per comprendere il pensiero del filosofo: una vita di dolore, fatiche ed incomprensioni ha fatto sì che la sua concezione dell’uomo sia intrisa di un radicale pessimismo;

Il filosofo godrà di fortuna e fama solo negli ultimi anni della sua vita, dopo essere vissuto all’ombra di Hegel, filosofo suo contemporaneo di grande successo e fama.
Questo pessimismo orienta la concezione dell’amore e del rapporto che il filosofo propone; per Schopenhauer, l’amore e i sentimenti non sarebbero che illusione; parte del più ampio inganno che la Natura intesse per orientare l’uomo, pedina inconsapevole, secondo i suoi fini.
Afferma il filosofo:
“Dunque qui, come in ogni istinto, la verità assume la forma dell'illusione per agire sulla volontà.
È un'illusione di voluttà quella che inganna l'uomo, facendogli credere che troverà tra le braccia di una donna di bellezza a lui confacente un piacere più grande che non fra quelle di qualsiasi altra; ed è la stessa illusione che, diretta esclusivamente a un'unica donna, lo persuade fermamente che il possederla gli procurerà una straordinaria felicità. […]
L'appagamento, invece, torna a vantaggio, propriamente parlando, solo della specie e non cade, quindi nella coscienza dell'individuo, che qui, animato dalla volontà della specie, serviva con ogni sacrificio uno scopo che non era assolutamente il proprio”

Illustrazione di Giulia Iaquinta
La concezione dell’amore e del rapporto con l’altro pone Schopenhauer in aperta opposizione ad un altro grande pensatore, il filosofo ateniese Platone. Se Platone, ne la Repubblica, propone il mito della ricerca eterna della metà perduta, per Schopenhauer l’esperienza di contatto con l’altro non può che essere un’illusoria forma di inganno, destinata ad alimentare un vissuto di insoddisfazione.
Per spiegare questa sua concezione, Schopenhauer ha proposto un’immagine divenuta famosa, la “metafora dei porcospini”:
“Una compagnia di porcospini, in una fredda giornata d'inverno, si strinsero vicini vicini, per proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine reciproche; il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l'uno dall'altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò di nuovo a stare insieme, si ripeté quell'altro malanno; di modo che venivano sballottati avanti e indietro fra due mali, finché non ebbero trovato
una moderata distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione."
Schopenhauer vede nelle spine del porcospino le inevitabili frustrazioni e delusioni che il contatto con l’altro comporta; una relazione, secondo il filosofo, non potrebbe che richiedere una continua serie di aggiustamenti, di avvicinamenti ed allontanamenti, per l’impossibilità di fare “Uno” con l’altro.
Prosegue Schopenhauer:
“Così il bisogno di società, che scaturisce dal vuoto e dalla monotonia della propria interiorità, spinge gli uomini l'uno verso l'altro; le loro molteplici repellenti qualità e i loro difetti insopportabili, però, li respingono di nuovo l'uno lontano dall'altro. La distanza media, che essi riescono finalmente a trovare e grazie alla quale è possibile una coesistenza, si trova nella cortesia e nelle buone maniere.
A colui che non mantiene quella distanza, si dice in Inghilterra: keep your distance! − Con essa il bisogno del calore reciproco è soddisfatto in modo incompleto, in compenso però non si soffre delle spine altrui. − Colui, però, che possiede molto calore interno preferisce rinunciare alla società, per non dare né ricevere sensazioni sgradevoli.”
Per il filosofo, data la radicale impossibilità di soddisfare nel mondo i propri desideri, è necessario optare per una scelta di moderazione e di ritiro rispetto ai propri desideri; essi andrebbero guardati con un crescente distacco, come una tentazione destinata a suscitare ulteriore dolore.

La metafora del porcospino di Schopehauer risente dell’influenza del pensiero del filosofo e poeta italiano Giacomo Leopardi: il richiamo alla solitudine e alle difficoltà che la vita impone all’uomo è un chiaro eco del pessimismo cosmico dell’autore dello “Zibaldone dei pensieri”.
Per approfondire:
-Arthur Schopenhauer - Parerga e paralipomena (1851);
-Umberto Galimberti – Schopenhauer e il pessimismo (2015).
Se da una parte la lettura di Schopenhauer critica l'impostazione platonica, il mito del "Fare Uno", allo stesso tempo si pone in continuità con l'aforisma lacaniano "Non c'è rapporto sessuale".
La metafora di Schopenhauer mostra l'impossibilità di realizzare il più noto tra i fantasmi dell'amore: divenire una cosa sola con l'altro.


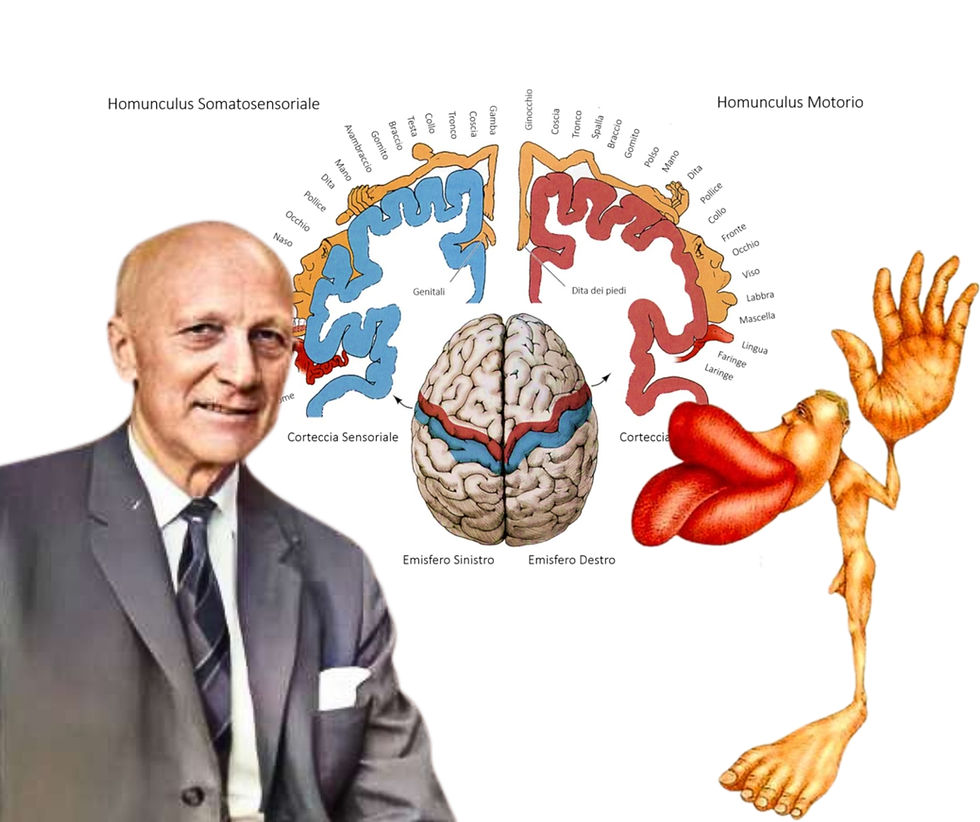
Molti, paradossalmente, sperimentano una maggiore solitudine nel nostro mondo iperconnesso, il che suggerisce che le intuizioni di Schopenhauer siano più attuali che mai. Per approfondire questa tradizione filosofica, si possono trovare eccellenti risorse e gioielli ispirati alla tradizione filosofica che possono fungere da promemoria quotidiani delle domande più profonde della vita. L'eredità di Schopenhauer sopravvive anche attraverso la sua influenza sull'esistenzialismo moderno e sulla psicologia umanistica. La sua consapevolezza che l'uomo è fondamentalmente solo, ma dipendente dagli altri, ha plasmato intere generazioni di pensatori e terapeuti. Queste riflessioni sull'esistenza umana continuano ad essere rilevanti per chiunque cerchi di comprendere la complessità delle relazioni umane e l'eterna domanda su quanto possiamo avvicinarci gli uni agli altri senza farci del male.
Un'affascinante riflessione sul…